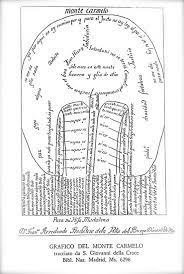C’è un viaggio, tra la metafora e il concetto, che attraversa il mare dell’interpretazione e approda alla terra del senso. La parola vive le avventure del pensiero, fa la spola tra le immagini e le idee, si tende sull’arco dell’allegoria per poi distendersi in una narrazione instabile. È il viaggio che San Giovanni della Croce sperimenta accanto all’altro viaggio, quello che lo porta, dopo tante persecuzioni subite da parte dei suoi confratelli, da Granada all’esilio.
L’esilio sulla Sierra Morena, in un convento che sorge in un luogo arido e desolato, dove Giovanni lavora nell’orto, dicendo di trovarsi meglio tra le pietre che tra gli uomini. «È bello manipolare queste creature morte», scrive, «piuttosto che essere manipolati da quelle da quelle vive». Ma Giovanni, oltre che pietre, manipola parole. E nel Cantico spirituale costruisce un commento mistico alle strofe delle sue Canzoni, scritte qualche anno prima, sotto l’ispirazione del Cantico biblico.
Commento? Niente di più lontano dalla spiegazione razionale, in prosa, delle immagini poetiche contenute nelle strofe in versi. Non è certo questa la strada imboccata da colui che fu sospettato d’eresia per aver introdotto nella fede dell’Occidente la preghiera mentale. Il suo Cantico, semmai, è un’avventura del linguaggio, una produzione di senso attraverso le peripezie dell’interpretazione.
«Lo spirito che vi è racchiuso è difficile da capire, è molto più abbondante della lettera e assai straordinario e al di fuori dei suoi limiti»: così Giovanni parla della propria poesia. E si accinge all’impresa di decifrare le metafore delle Canzoni – commenta Norbert von Prellwitz – come un archeologo che decifri strani geroglifici.
Non parafrasi delle immagini. Non riduzione del volume di senso della poesia. Non razionalizzazione della metafora. Semmai Giovanni riproduce e moltiplica nella prosa del Cantico gli echi delle strofe. Non si ferma, da mistico, di fronte all’ineffabile proponendo come unica medicina il silenzio. Né gli basta «l’oscura balbuzie delle definizioni razionali». Si incammina sul sentiero incerto delle parole e costruisce uno stile dove la reiterazione, la sovrabbondanza, la ridondanza creano espansione cumulativa.
L’iperbole dell’iterazione («Io sarò te nella tua bellezza, e tu sarai me nella tua bellezza. E così ci vedremo l’un l’altro nella tua bellezza»: nel brano che si conclude così, la parola bellezza è ripetuta venti volte in poche righe) sfocia nell’enigma:
e poi mi donerai
là quello, vita mia,
che l’altro giorno tu mi hai già donato.
«Quello»: il pronome smarrisce il nome a cui si riferisce. Diventa vuoto, dimostrativo del nulla, riferimento impossibile. Ma acquista «un contenuto virtuale infinito» (von Prellwitz). Poi il cerchio dell’interpretazione riprende a girare. Si riapre e si richiude. Trova altre immagini in cui rifrangersi, altri enigmi in cui riposare per poi, di nuovo, inseguire altre immagini in cui l’enigma ritorna a muoversi. Il viaggio, allora, è peripezia interminabile tra le metafore delle Canzoni e i concetti del Cantico.
Ma le metafore passano attraverso i concetti e i concetti grondano metafore. L’interpretazione diventa «esercizio spirituale»: inizia con una mortificazione – lo svuotamento della poesia di ogni significato che potrebbe aver assunto in precedenza. Giovanni esercita il distacco completo perfino dalla propria poesia. Solo così è possibile affrontare il testo con occhi sempre nuovi, diventare davvero padroni di ciò che si crede di possedere.
Ma la «scienza saporosa» di Giovanni della Croce, conoscenza che è sintesi di sapere e sapore, esce dal ghetto della mistica cinquecentesca e, oggi, fornisce indizi al pensiero in cerca di soluzioni per la conoscenza, dopo la grande crisi tra i due secoli: quando la cultura dell’Occidente, malgrado abbia imparato il metodo della preghiera mentale, prende coscienza che ormai è impossibile dare nome alle cose:
I misteri della Fede si sono composti per me in una nobile allegoria che posa sopra la distesa della mia vita come un arcobaleno splendente, sempre remoto, sempre pronto a scomparire se mai pensassi ad avvicinarmi e a volermi avvolgere nel lembo del suo mantello. Però, egregio amico, anche i concetti terreni mi sfuggono alla stessa maniera.
Così Hugo von Hofmannsthal, quattro secoli dopo Giovanni della Croce, confessa nella sua Lettera di Lord Chandos l’impotenza delle parole di fronte al mondo, la deriva dell’io davanti alle cose. «Per farla breve: allora, in una sorta di costante ebbrezza, tutto quanto esiste mi appariva come una grande unità»: Lord Chandos avverte che è ormai superata la divisione delle cose nel mondo, quella divisione avvenuta sulla base del nome loro assegnato. «Intuivo», continua Lord Chandos, «che tutto era identità, e ogni creatura la chiave per un’altra, e mi sentivo come colui che doveva essere in grado di afferrarle una dopo l’altra e di schiuderne tante altre con essa, quante quella ne potesse disserrare».
Se, come ha scritto Claudio Magris, la Lettera di von Hofmannsthal «costituisce un manifesto del deliquio della parola e del naufragio dell’io nel convulso e indistinto fluire delle cose non più nominabili né dominabili dal linguaggio», allora la ricerca di Giovanni della Croce, il suo viaggio della parola, indica oggi sentieri difficili ma ripercorribili. Offre indizi a chi, come il personaggio dell’Auto da fé di Elias Canetti, non ha altra scelta che indicare il medesimo oggetto ogni volta con un termine diverso, per non cadere prigioniero del potere della definizione, secca e immutabile.
Che qualche indicazione per parlare, cioè per vivere, nel «tempo della povertà» (come lo chiama Martin Heidegger, citando Hölderlin), nell’epoca in cui «Dio è morto», venga da un mistico nato, vissuto e perseguitato nella cattolicissima Spagna, non può sviare. Siamo dentro il medesimo smarrimento, o dentro la medesima avventura. Spezzata l’illusione della perfetta corrispondenza tra i nomi e le cose, non resta altra strada che il viaggio dell’interpretazione.