Cruchi, le prime pagine
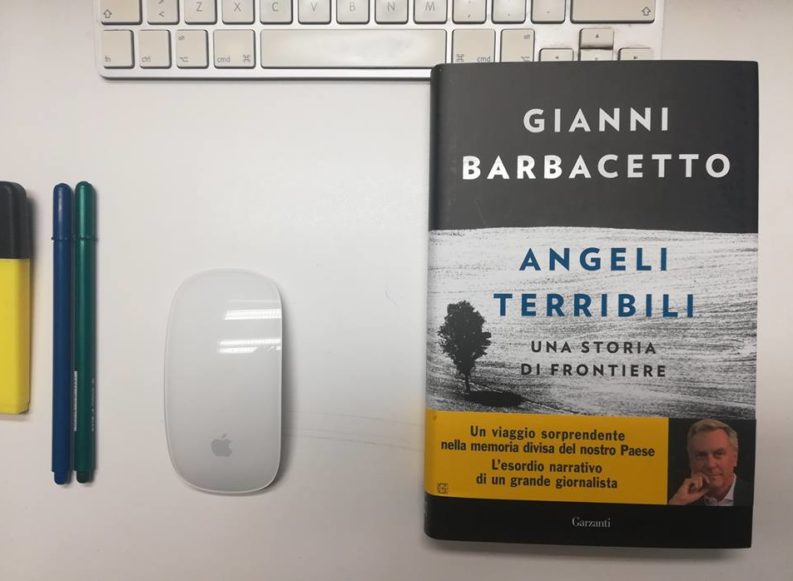
Così inizia il libro:
Qui giace Cruchi
uomo iniquo e perverso
pregare per lui
è tempo perso.
Così era scritto sulla tomba di un uomo morto sul finire della seconda guerra mondiale. Era stato sepolto nel piccolo cimitero di Ravascletto, in Carnia, quel pezzo di Friuli fatto di monti e di valli incuneate nell’estremo angolo d’Italia a nord del nord-est, al confine con l’Austria. In Carnia, il cielo è metallico. Quando c’è il sole, sembra uguale ai cieli di ogni altro luogo, ma basta che arrivi qualche nuvola ad annunciare il prossimo, frequente scroscio di pioggia, perché sopra le creste dei monti si stenda il piombo fuso di un cielo liquido e in eterno movimento. Sotto questo cielo è stato scritto il terribile epitaffio, la cui memoria era tramandata di bocca in bocca dai vecchi che avevano vissuto quegli anni spietati.
Da Ravascletto vengono i miei genitori, arrivati a Milano, in cerca di lavoro, dopo la fine della guerra. L’epitaffio lo avevo sentito per la prima volta recitare dalla zia Tea, che aveva qualche anno più di mia madre e nel 1945, quando la guerra finì, aveva già vent’anni. Ma per la mia immaginazione di bambino, quella di Cruchi era una storia come tante altre che sentivo raccontare, la sera, nel friulano dolce e duro della Carnia, da mio padre o da zio Lele o da altri arrivati nel dopoguerra a Milano dal paese, raccolti attorno a un tavolo con la tovaglia di tela cerata su cui volavano le carte da briscola e si riempivano i bicchieri di vino rosso: storie di streghe e incantesimi, di preti maghi, di violinisti gobbi, di balli al suono della fisarmonica, di sfide per una ragazza tra i giovani di Monài e quelli di Giuvièl, di amori, di miseria, di guerra.
Chissà se era vero, l’epitaffio di Cruchi. Chissà se Cruchi era davvero esistito, oppure era soltanto uno dei tanti personaggi creati dalla fantasia dei vecchi che raccontavano storie, la sera. Ma se era vero, chi era, Cruchi? Che cosa aveva fatto, per guadagnarsi quel giudizio crudele, per non meritare neppure una preghiera che, una volta morto, non si nega al peggiore degli uomini?
La storia di Cruchi restò a galleggiare nella mia mente come tante altre storie, comiche o licenziose o drammatiche, che avevo sentito raccontare da bambino, da mio padre o dagli zii o dagli altri del paese, durante le serate d’inverno a Milano quando ero ancora a tavola con gli adulti, oppure quando ero già a letto, cullato dalle parole dei grandi che, senza più i bambini attorno, si sentivano liberi di usare toni più crudi o più piccanti o di toccare argomenti che non si potevano affrontare con i piccoli presenti: la vita, l’amore, il sesso, la morte. Ma quella di Cruchi era diversa dalle altre storie. Meno magica, più dura, più reale.
Diventato adulto, ogni tanto riaffiorava nella mia mente, riportata a galla da un accenno, da un ricordo, da un’associazione di idee. Io conoscevo bene quel piccolo cimitero di montagna dove l’epitaffio sarebbe stato scolpito –nella pietra? nel legno? – perché nelle lunghe estati in cui mia madre mi riportava da Milano a Ravascletto, la domenica, prima o dopo la messa, noi bambini un giro tra le tombe lo facevamo volentieri, a guardare i nomi, le epigrafi, i fiori di campo. Per poi correre subito fuori, nei prati attorno alla chiesa di San Matteo, o per andare a guardare il sacrestano, Svualdìn, appendersi alla grossa fune che faceva suonare squillanti e un po’ stonate le campane.
Una notte di festa, lasciati gli adulti alle loro musiche al suono della fisarmonica e ai loro balli, fui trascinato dai miei cugini e dai loro amici giù, fino al cimitero, tra risate di sfida e brividi di paura. I più grandi dicevano che dovevamo correre tra le tombe battendo forte i piedi, per vedere comparire le anime dei morti. Avevo cinque anni. Tremavo dal terrore, ma ero come ipnotizzato dalla sfida: era bello correre all’impazzata insieme agli altri ragazzi che ridevano troppo per non avere proprio alcun timore.
Le vidi, quella notte, le anime dei morti. Fiammelle azzurrognole che nuotavano sospese a poca distanza dalla terra e pareva ci rincorressero. I fuochi fatui dei trapassati che volevano tornare a correre e a ridere con i bambini che un tempo anche loro erano stati e che tornavano a sfidare la paura, annullando, per il tempo di una corsa con il cuore in gola, le distanze tra i morti e i vivi.
Strana posizione, quella del cimitero, della chiesa e del campanile. Non in mezzo al paese, oppure più a monte, a dominare le case, come accade di solito nei borghi di montagna. No, a Ravascletto il paese è più in alto, a mezza costa, affacciato sulla Valcalda, a guardare, di fronte, il monte Cioncolàn, coperto di boschi di faggi e di abeti e, su in alto, di fitte boscaglie d’ontano. Alle spalle, ha i 2 mila e passa metri del Cimon di Crasulina e del Mont di Crostes, tra cui si inarca una sella incantata con i laghetti alpini di Tarond, Tarondut e Crasulina.
Il paese è composto da gruppi di vecchie case di pietra che formano la frazione di Stàles, poi, andando verso est, quella di Monài, verso ovest quella di Salàrs, unite da un’unica strada che si arrampica fin quassù da Comeglians e arriva fino a Tualies. Monài, Stàles e Salàrs formano il Comune di Ravascletto, che a Monài ha il suo municipio. C’è una quarta frazione, un poco più distante: Giuvièl, da cui proviene mio padre, borgo che si affaccia sulla strada che va dalla parte opposta, verso est, e poi scende a Ciurciuvìnt e Palucia.
Ogni borgo ha la sua chiesa. Santo Spirito, a Monài, è stata risistemata e ampliata ai primi dell’Ottocento a partire da una chiesetta cinquecentesca; all’interno, due arcangeli di legno dipinto e dorato, scuola bavarese di inizio Settecento, guardano trasognati i rari visitatori. San Giovanni, a Salàrs, è la figlia ottocentesca di diversi tentativi, fin dal Seicento, d’edificare una chiesetta su terreni franosi e sismici; anche qui santi, angeli e una Madonna che con grazia profana s’accinge al suo Matrimonio mistico: tutti dipinti da pittori della Baviera. Sant’Andrea, a Giuvièl, è in cima al paese, sistemazione ottocentesca di una chiesetta del Cinquecento, con qualche segno – una bifora, un mascherone – del Trecento, come il crocifisso in bronzo conservato nel tesoro della chiesa.
Infine c’è San Matteo, la chiesa grande, la parrocchiale, quella del cimitero in cui danzano le anime dei morti. Costruita nel Settecento, ha in sacrestia due piccoli dipinti di quel secolo che raffigurano Gesù e Maria che espongono il cuore: una iconografia splatter che viene, anche questa, dalla Baviera. San Matteo è più in basso del paese, quasi a fondovalle. Davanti ha il camposanto, circondato da un muro di pietra non troppo alto per essere scavalcato dai ragazzi, e poco distante il massiccio campanile bianco con modonature di tufo grigio e la cuspide a cipolla. Per arrivare alla chiesa, bisogna imboccare una strada che scende ripida a semicerchio, tra i campi, dalle ultime case di Stales fino al campanile di San Matteo. Tutt’attorno prati, campi, ruscelli, boschetti.
È la Valcalda, la valle con al centro Ravascletto su cui si affacciano i paesi in cui si svolge la storia di Cruchi, «uomo iniquo e perverso»: Comeglians e Palucia, Tuàlies e Giuvièl. A guardare la cartina geografica, la Valcalda è la stanghetta orizzontale di una grande H le cui aste sono a ovest il Canale di Gorto, che da Forni Avoltri scende a Villa Santina, e a est il Canale di San Pietro, che dal Passo di Monte Croce Carnico arriva giù fino a Tolmezzo.
Ma Valcalda? La storia di Cruchi nasce fin dall’inizio dentro un equivoco, una cosa scambiata per il suo contrario. Il nome Valcalda è un errore dei volonterosi geografi italici che, alle prese con la cartografia tedesca, tradussero a orecchio. Così “kalt” divenne “calda”, però vuol dire fredda. La Valcalda è, in realtà, Valfredda. Ma forse, chissà, non sbagliarono affatto. Semplicemente migliorarono la realtà, cercando di tirar fuori dalle parole il loro meglio. «Una parola è un incantamento, una evocazione allucinatoria», scriveva Giorgio Manganelli, «non designa una cosa, ma la cosa diventa parola, ed esiste nell’unico modo in cui può esistere: suono significante, arbitrio fonico, gesto magato ed efficace». Comunque sia, i solerti cartografi che hanno inventato la Valcalda hanno segnato per i secoli successivi al loro intervento la realtà degli eventi e dei loro racconti, mentre le temperature, comunque, hanno continuato a non curarsi affatto della sorte che era stata loro assegnata.
Così inizia “Angeli terribili”, il nuovo libro di Gianni Barbacetto


